Fare buona politica all’epoca del trasformismo
In un post di qualche giorno fa ho ironizzato sui flussi e riflussi di candidati che in occasione delle elezioni si spostano da una lista all’altra finché non trovano una collocazione soddisfacente, anche a costo di approdare in partiti molto diversi da quelli in cui hanno militato fino a quel momento.
In realtà, adesso che la campagna elettorale per le regionali è in corso e sono meglio apprezzabili i movimenti che ci sono stati, ci si rende conto che non si tratta solo di deprecabili singoli a caccia di un posto, uno qualunque, dove spendere il  proprio pacchetto di voti personale, ma anche di gruppi semi-strutturati che le correnti della politica hanno scozzato dal loro ancoraggio e rigettato verso altri porti-partiti più o meno affini. Per dire: un pezzo della corrente del PD di Paolo Fadda se n’è andato in Sardegna Possibile, Maninchedda e Sedda da opposte sponde si sono trovati nel Partito dei Sardi, i Verdi stanno dentro l’Italia dei Valori che però ha perso un pezzo che se n’è andato nei Rossomori…
proprio pacchetto di voti personale, ma anche di gruppi semi-strutturati che le correnti della politica hanno scozzato dal loro ancoraggio e rigettato verso altri porti-partiti più o meno affini. Per dire: un pezzo della corrente del PD di Paolo Fadda se n’è andato in Sardegna Possibile, Maninchedda e Sedda da opposte sponde si sono trovati nel Partito dei Sardi, i Verdi stanno dentro l’Italia dei Valori che però ha perso un pezzo che se n’è andato nei Rossomori…
… incidentalmente, il confronto fra la qualità relativa di questi due ultimi gruppi dà un risultato impietoso che indica che probabilmente nel contrasto fra Giommaria Uggias e Giovanni Dore ha ragione quest’ultimo…
… ma non è questo il discorso che volevo fare. Quello che volevo raccontarvi è che la diversa qualità relativa della varie mosse di riposizionamento mi ha fatto pensare, e adesso non sono più così sicuro.
Dal partito al trasformismo

Siccome mia mamma quando non aveva nessuno a cui lasciarmi mi portava alla sezione Lenin di via Leopardi e poi sono stato nell’AC dove erano tutti (quasi tutti: io no) democristiani è chiaro che sono di un’epoca e ho una formazione per le quali la mia idea naturale di partito è quella del partito di tipo associativo, con una adesione formale (la tessera), una struttura organizzativa più o meno importante, dei dirigenti, dei militanti, soprattutto, e così via. Un modello attualmente del tutto in crisi: basta vedere il coacervo di correnti e spezzoni diversi che oggi è il PD, tenuto insieme non si sa bene come.
Non è però che il modello alternativo, il partito di tipo movimentista reso vincente da Berlusconi negli ultimi anni, se la passi meglio: basta pensare al fallimento del M5S per queste ultime regionali, alla difficoltà di Berlusconi stesso a fermare l’implosione del centro-destra… gli ultimi anni dimostrano che il modello del partito-movimento, fluido, legato più a parole d’ordine che a strutture organizzative, va incontro con troppa facilità a un mutamento di stato che da liquido lo rende… gassoso e quindi incontenibile anche per la leadership dell’uomo forte.
C’è poco da fare: il modello vincente, oggi, è quello del gruppo. Un piccolo gruppo più o meno coeso di attori politici con idee comuni, spesso legati a un singolo più brillante, o ricco, o forte, o bravo, o ammanigliato. Un piccolo gruppo fortemente radicato territorialmente, in modo da avere sempre una base di potere da cui ripartire, oppure legato a un interesse specifico di cui si fa espressione. Gruppetti che si combinano e ricombinano a seconda del momento, dell’occasione politica, dei temi. Gruppetti che stanno dentro contenitori più grandi, i partiti, le coalizioni, ma senza mai annullarsi del tutto dentro queste identità maggiori: se va bene ne orientano la direzione verso i propri fini, se non va almeno vanno a traino e sopravvivono; se va proprio male cercano collocazioni migliori altrove.

È il modello del trasformismo ottocentesco. “Trasformismo” non è una parola che abbia una buona fama, in italiano, ma qui la uso in senso tecnico. Nel modello costruito da Depretis convergeva la stragrande maggioranza dei parlamentari, con una comune appartenenza sociale borghese, con valori di base comuni (la Patria, lo Statuto Albertino, la Monarchia) e un ampio ventaglio di posizioni e sensibilità diverse sui singoli temi e sulle varie questioni politiche del momento: posizioni che Depretis lasciava che si combinassero e ricombinassero a seconda delle occasioni, per far andare avanti più o meno sempre nella stessa direzione la propria agenda politica, ma con maggioranze di volta in volta mutevoli.
Al trasformismo delle appartenenze corrispondeva, peraltro, anche un trasformismo delle soluzioni ai problemi: Depretis non aveva problemi ad adottare talvolta soluzioni “di destra”, e uomini della Destra a sostenere soluzioni “di sinistra”. Diceva Depretis:
Le idee buone, le vere utili esperienze, le prenderò dove che sia, anche dai nostri avversari
frase che richiama in maniera sinistra certe cose da “governo dei tecnici”, best practices de noantri, degenerazioni della democrazia partecipativa e altre posizioni sul genere di: «qui si lavora e non si fa politica».
Va detto che la dissoluzione dei due partiti della Sinistra e della Destra dopo l’Unità d’Italia non era opera di una qualche diabolica capacità corruttiva di Depretis ma era effetto piuttosto di fattori sociali ben precisi: la comune appartenenza di ceto di chi faceva politica, da cui discendeva comunanza di idee, interessi e valori, il fatto che i portatori di idee radicalmente diverse, cattolici a destra e socialisti a sinistra, fossero del tutto esclusi dal gioco politico, la mancanza di un vero punto del contendere fra i partiti tradizionali, approdati entrambi sostanzialmente a una visione di riformismo molto moderato… Il che non vuol dire che il trasformismo non abbia portato conseguenze negative alla società italiana: strapotere dei gruppi di interesse economico, distacco della politica da vasti strati della società, corruzione, perdita di credibilità e di tensione ideale della politica, mancanza di visione strategica per il futuro; ma non era colpa di Depretis (e, in generale, nemmeno di ciascun singolo deputato) e infatti il sistema continuò anche con Crispi e in parte con Giolitti, finché l’irrompere nel minuetto della politica liberale della mazurca dei movimenti popolari non fece cambiare completamente la musica.
 È una situazione che ha forti somiglianze con l’attuale, e lo dico anche a me stesso per togliere di mezzo un po’ del moralismo che spesso usiamo a proposito della nostra politica. Il mio modello di partito è un altro, la situazione attuale non mi piace e se un politico ruba gli va sempre detto che è un mascalzone, ma se il sistema dei partiti è in crisi non può dipendere solo dal fatto che i politici sono ladri o non sono all’altezza, scambiando l’effetto con le cause: casomai dipenderà dal fatto che adesso come all’epoca di Depretis la maggior parte di coloro che fanno politica appartengono a uno stesso gruppo sociale e condividono un fascio largamente comune di convinzioni e di valori (e borghese e liberale, sostanzialmente: libertà di consumo, individualismo, l’Europa dei poteri forti…) anche perché il sistema ha interiorizzato e anestetizzato una serie di tensioni sociali e ha totalmente emarginato dal gioco politico tutto il resto che non poteva ingurgitare. E un ceto politico sostanzialmente privo di motivi di divisione, in cui capita che componenti della stessa famiglia siano eletti in schieramenti opposti, finirà fatalmente per perdere la tensione ideale e per differenziarsi sulla base di questioni contingenti, fra le quali le questioni territoriali (dai nazionalismi agli indipendentismi ai localismi alle varie sindromi NIMBY), di bottega e di interesse non potranno che diventare prevalenti.
È una situazione che ha forti somiglianze con l’attuale, e lo dico anche a me stesso per togliere di mezzo un po’ del moralismo che spesso usiamo a proposito della nostra politica. Il mio modello di partito è un altro, la situazione attuale non mi piace e se un politico ruba gli va sempre detto che è un mascalzone, ma se il sistema dei partiti è in crisi non può dipendere solo dal fatto che i politici sono ladri o non sono all’altezza, scambiando l’effetto con le cause: casomai dipenderà dal fatto che adesso come all’epoca di Depretis la maggior parte di coloro che fanno politica appartengono a uno stesso gruppo sociale e condividono un fascio largamente comune di convinzioni e di valori (e borghese e liberale, sostanzialmente: libertà di consumo, individualismo, l’Europa dei poteri forti…) anche perché il sistema ha interiorizzato e anestetizzato una serie di tensioni sociali e ha totalmente emarginato dal gioco politico tutto il resto che non poteva ingurgitare. E un ceto politico sostanzialmente privo di motivi di divisione, in cui capita che componenti della stessa famiglia siano eletti in schieramenti opposti, finirà fatalmente per perdere la tensione ideale e per differenziarsi sulla base di questioni contingenti, fra le quali le questioni territoriali (dai nazionalismi agli indipendentismi ai localismi alle varie sindromi NIMBY), di bottega e di interesse non potranno che diventare prevalenti.
E quando ciò che conta sono solo le questioni di interesse e il sistema politico è privo della possibilità di ricambio globale la corruzione non potrà che essere dilagante. Allora come adesso.
 Non mi piace e non è il mio modello, ma è la situazione che vive la società italiana e che presumibilmente ci trascineremo dietro per un po’: non vorrei preoccuparvi ma per liberarsi del primo trasformismo l’Italia ci ha messo vent’anni e si è dovuta sorbire un intervento disastroso nella I Guerra Mondiale che l’ha portata dritta dritta al fascismo. Apprezzo molto i tentativi che fa Fabrizio Barca per ricostruire il PD come partito-partito ma non è pensabile che l’Italia torni al meccanismo dei partiti popolari della I Repubblica in tempi brevi, e temo che in realtà Barca stesso per quanto bravissimo sottovaluti la forza dei meccanismi sociali che lavorano per la polverizzazione della rappresentanza politica.
Non mi piace e non è il mio modello, ma è la situazione che vive la società italiana e che presumibilmente ci trascineremo dietro per un po’: non vorrei preoccuparvi ma per liberarsi del primo trasformismo l’Italia ci ha messo vent’anni e si è dovuta sorbire un intervento disastroso nella I Guerra Mondiale che l’ha portata dritta dritta al fascismo. Apprezzo molto i tentativi che fa Fabrizio Barca per ricostruire il PD come partito-partito ma non è pensabile che l’Italia torni al meccanismo dei partiti popolari della I Repubblica in tempi brevi, e temo che in realtà Barca stesso per quanto bravissimo sottovaluti la forza dei meccanismi sociali che lavorano per la polverizzazione della rappresentanza politica.
Fare buona politica all’epoca del trasformismo
E quindi se la situazione è questa mi è venuto da pensare che l’importante non è tanto il mutare delle posizioni formali (cioè stare a vedere qual è il simbolino sotto cui uno si candida) ma magari qualcos’altro. Un criterio che spieghi perché sia comunque ragionevole ritenere che fra transfuga e transfuga, fra gruppo e gruppo, fra cordata e cordata corrano in ogni caso degli abissi che rendono il giudizio politico sulle scelte di ciascuno radicalmente differente.
Ecco, quello su cui mi interrogo in questo periodo è: qual è questo criterio che dice come si fa a fare buona politica nel momento in cui le appartenenze forti e i partiti che si scelgono per la vita divengono opzioni non più praticabili? Nel momento in cui i percorsi personali divengono per forza di cose tortuosi?
È una ricerca utile per chi, come me, giudica dall’esterno in quanto elettore. Ma penso che sia una ricerca da intraprendere soprattutto per quelle persone oneste e brave che lavorando direttamente in politica sono costrette a fare i conti con contesti che gli cambiano intorno con grandissima velocità. Come si fa a fare buona politica nel momento in cui i percorsi sono praticamente sempre personali, raramente collettivi? Prima c’era il partito, e tu gli andavi dietro. Prima c’era la sezione o la parrocchia o l’azienda o il sindacato, che erano tuoi come di tutti: adesso ti fai la tua fondazione o la tua associazione su misura e poi apri un blog. E poi, suppongo, ti chiedi: e adesso? Adesso devi fare strada da solo e trovarti da solo la direzione.
 È un tema che mi interessa molto e su cui mi farebbe anche piacere trovare qualcuno con cui discutere. In questi giorni alcune risposte me le sono date da solo ma sono forzatamente provvisorie. Le propongo qui sul blog con la curiosità di vedere che effetto fanno; naturalmente arrivano dopo le basi, che sono in ogni tempo le stesse: che per fare buona politica occorre sempre essere competenti, avere occhi per vedere, essere onesti intellettualmente, non rubare, non mentire, fuggire il conflitto d’interessi – mi spiace se criteri così di base eliminano comunque buona parte della platea delle prossime regionali, anche in posizioni apparentemente insospettabili.
È un tema che mi interessa molto e su cui mi farebbe anche piacere trovare qualcuno con cui discutere. In questi giorni alcune risposte me le sono date da solo ma sono forzatamente provvisorie. Le propongo qui sul blog con la curiosità di vedere che effetto fanno; naturalmente arrivano dopo le basi, che sono in ogni tempo le stesse: che per fare buona politica occorre sempre essere competenti, avere occhi per vedere, essere onesti intellettualmente, non rubare, non mentire, fuggire il conflitto d’interessi – mi spiace se criteri così di base eliminano comunque buona parte della platea delle prossime regionali, anche in posizioni apparentemente insospettabili.
Appurate le basi, una prima cosa che penso è che comunque occorre dubitare di quelli che fanno capriole troppo complicate, o meglio: un filo rosso di continuità ideale dovrebbe essere sempre identificabile. Quando l’unico elemento che giustifica le scelte tattiche contingenti, i cambi di casacca e la costituzione di nuove aggregazioni è la pura e semplice sopravvivenza politica personale – o la possibilità di conseguire una promozione o maggiore visibilità – non è probabile che chi si pone questi obiettivi faccia buona politica.
Qualcosa di più delle qualità personali ci dovrebbe essere, diciamo, anche per giustificare il fatto di essere in politica e continuare a starci. E infatti è lecito dubitare anche di quelli che non stanno mai fermi un giro e che hanno sempre bisogno di riproporsi, come la peperonata: nessuno è così indispensabile, a meno che non abbia un proprio orticello da curare che richiede di non lasciare la stanza dei bottoni nemmeno per un attimo. Ma in quel caso è indispensabile a se stesso, gli elettori ne possono tranquillamente fare a meno.
Non è solo una questione di moralità personale: è che il trasformismo tende a racchiudere il gioco politico fra élites autocentrate, che si fanno portatrici di interessi particolari che ben presto diventano poi lotta per la supremazia fine a se stessa oppure banale prosecuzione dell’economia con altri mezzi, e il mantenimento di una certa tensione ideale è invece il segnale di una salute minima del sistema, così come è un buon segno che si combattano i meccanismi oligarchici evitando di interpretare la politica come cursus honorum da percorrere dall’inizio alla fine e come professione permanente: la buona politica al tempo del trasformismo dovrebbe dimostrare che c’è un tempo per tutto, secondo la saggezza del Qoèlet:
Per ogni cosa c’è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo.
C’è un tempo per nascere e un tempo per morire,
un tempo per piantare e un tempo per sradicare le piante.
[…]
Un tempo per cercare e un tempo per perdere,
un tempo per serbare e un tempo per buttar via.
Un tempo per stracciare e un tempo per cucire,
un tempo per tacere e un tempo per parlare
e non credo che facciano buona politica quelli che sono uomini adatti per tutte le stagioni.
Tornando alle élite un altro elemento su cui in questo periodo rifletto molto deriva dal vecchio slogan di Porto Alegre: pensare globalmente e agire localmente. Per esempio che degli italiani mettano in piedi un progetto di una lista per le europee che abbia come leader il greco Tsipras secondo me è buona politica: si può condividere oppure no ma dimostra visione strategica, capacità di andare oltre i propri confini e legare la propria azione politica a quadri generali, nel caso specifico una visione di Europa, uscendo dall’individualismo delle posizioni autonome. Il problema di queste regionali è che invece ci sono dei segnali che si tenda, al contrario, a pensare localmente – cioè alla possibilità di un proprio predominio locale – e agire globalmente – mobilitando risorse e reti e alleanze per il sostegno a posizioni politiche individuali. Per uscire dal vago: se si pensa di vincere esclusivamente perché viene Renzi o Berlusconi a dare fiato alla grancassa o perché si è in grado di mobilitare il sistema mediatico nazionale e le amicizie letterarie e giornalistiche nazionali – anche queste sono grancasse – vuol dire sostanzialmente che si fa una politica da baroni e proconsoli di imperi, papati o poteri forti vari e che allo stesso modo la si farebbe altrove, e tanti saluti a coloro ai quali si chiede il voto; non saranno i propri rappresentati che contano, ma il rispetto delle alleanze che hanno portato all’elezione. Quando ci sono élite che si appoggiano ad altre élite di altrove normalmente si segnala che si hanno le mani in pasta, che ci sono conflitti di interesse potenziali o in corso, che si è portatori non di interessi collettivi ma di interessi… ramificati, il che non è proprio la stessa cosa. Vale a tutti i livelli: in queste elezioni non si vedono solo candidati presidenti e candidati consiglieri impegnatissimi a capitalizzare rendite di posizione nazionali ma anche una folla di portatori d’acqua che si spendono per questo o quell’altro capobastone candidato senza che sia molto chiara la motivazione di tanto impegno, se non un rapporto di vassallaggio.
Infatti è sorprendentemente ingenua l’idea che uno che non ha mai governato sia per questo stesso motivo onesto, ingenua fino al limite della mistificazione: perché è più che possibile essersi sporcati le mani con appartenenze, alleanze e favori da rendere ben prima di essere andati in tipografia a stampare il santino elettorale.
 Non farei finanza etica se non mi fossi dato anche una risposta che riguarda l’uso del denaro. Passo per la città in questo periodo e vedo dappertutto uffici elettorali di singoli candidati. Immagino che non avendo più sezioni a cui appoggiarsi siano una necessità. Ma mi chiedo con che soldi vengono pagati. O meglio: mi pare che se per fare politica serve per forza pagare l’affitto di un ufficio elettorale, arredarlo, metterci un apparato di comunicazioni, pagare delle segretarie, diventa necessario essere ricchi di famiglia, il che riporta alla questione delle oligarchie e non è un gran segnale, o farsi finanziare da chi è ricco, che è ancora peggio, oppure dare a intendere che dopo eletti si rientrerà in qualche modo, il che è già l’anticamera del malaffare. Secondo me un finanziamento che si appella a un sostegno popolare, anche in mancanza di una struttura di partito tradizionale, va nella direzione giusta: diciamo che fra il citato Fabrizio Barca che finanzia il suo progetto col crowdfunding e chi butta nella campagna elettorale trentamila euro di risparmi propri preferisco senz’altro il primo: perché c’è più popolarità, più responsabilità di fronte a terzi, più trasparenza, e nell’uso del denaro sono tutte cose importanti.
Non farei finanza etica se non mi fossi dato anche una risposta che riguarda l’uso del denaro. Passo per la città in questo periodo e vedo dappertutto uffici elettorali di singoli candidati. Immagino che non avendo più sezioni a cui appoggiarsi siano una necessità. Ma mi chiedo con che soldi vengono pagati. O meglio: mi pare che se per fare politica serve per forza pagare l’affitto di un ufficio elettorale, arredarlo, metterci un apparato di comunicazioni, pagare delle segretarie, diventa necessario essere ricchi di famiglia, il che riporta alla questione delle oligarchie e non è un gran segnale, o farsi finanziare da chi è ricco, che è ancora peggio, oppure dare a intendere che dopo eletti si rientrerà in qualche modo, il che è già l’anticamera del malaffare. Secondo me un finanziamento che si appella a un sostegno popolare, anche in mancanza di una struttura di partito tradizionale, va nella direzione giusta: diciamo che fra il citato Fabrizio Barca che finanzia il suo progetto col crowdfunding e chi butta nella campagna elettorale trentamila euro di risparmi propri preferisco senz’altro il primo: perché c’è più popolarità, più responsabilità di fronte a terzi, più trasparenza, e nell’uso del denaro sono tutte cose importanti.
 E poi c’è la questione delle questioni, che è quella che riguarda la domanda: vogliamo il trasformismo per sempre? Ci va bene l’oligarchia? Il mio amico Enrico Lobina mi ricorda sempre che viviamo in una città in cui una parte amplissima dell’elettorato non segue i blog, non ascolta Buongiorno Cagliari, non legge il giornale ed è fuori da qualunque meccanismo di partecipazione politica; è ovviamente in queste aree – non necessariamente a basso reddito – che si trova il serbatoio delle clientele e dei voti di scambio. Vale per Cagliari e varrà per tutto il Paese. È chiaro che in un contesto del genere non si può parlare di democrazia: il modello del trasformismo è un modello in cui pochi, abbienti e garantiti presidiano la politica, e molti altri, non abbienti, non garantiti, non preparati o semplicemente stufi rimangono tagliati fuori: basta vedere dove stanno andando i tassi d’astensionismo. E quindi secondo me è buona politica quella che allarga il campo della partecipazione politica, perché contribuisce a porre le premesse per il superamento di una politica di individui e fa tornare quella che mi piace, cioè una politica di popolo.
E poi c’è la questione delle questioni, che è quella che riguarda la domanda: vogliamo il trasformismo per sempre? Ci va bene l’oligarchia? Il mio amico Enrico Lobina mi ricorda sempre che viviamo in una città in cui una parte amplissima dell’elettorato non segue i blog, non ascolta Buongiorno Cagliari, non legge il giornale ed è fuori da qualunque meccanismo di partecipazione politica; è ovviamente in queste aree – non necessariamente a basso reddito – che si trova il serbatoio delle clientele e dei voti di scambio. Vale per Cagliari e varrà per tutto il Paese. È chiaro che in un contesto del genere non si può parlare di democrazia: il modello del trasformismo è un modello in cui pochi, abbienti e garantiti presidiano la politica, e molti altri, non abbienti, non garantiti, non preparati o semplicemente stufi rimangono tagliati fuori: basta vedere dove stanno andando i tassi d’astensionismo. E quindi secondo me è buona politica quella che allarga il campo della partecipazione politica, perché contribuisce a porre le premesse per il superamento di una politica di individui e fa tornare quella che mi piace, cioè una politica di popolo.
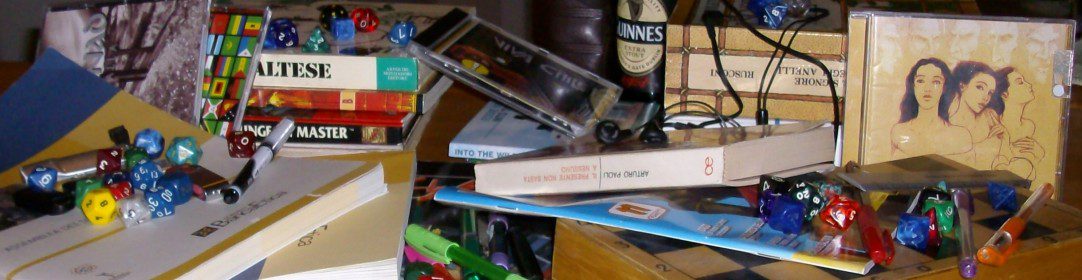


Sui gruppetti. Una mia riflessione forse sbagliata: la frammentazione dei partiti in tanti piccoli gruppi mi sembra corrispondere alla frammentazione dell’informazione in tante piccole fonti, cosi’ tanti dettagli – e alla continua presenza pressante delle informazioni (attraverso i potenti mezzi della tecnologia 😉 ).
Infatti non c’e’ piu’ solo il tema della difesa dell’ambiente naturale, ma mille piccoli temi (infatti, neanche un tema come la salubrita’ degli alimenti che mangiamo riesce a restare “intero” ma si frammenta subito in mille sottotemi); non c’e’ piu’ il tema dell’unione Europea, ma un caos (a me appare cosi’ nelle notizie) di cose tra rappresentanza politica, burocrazia, problemi finanziari, amministrazione delle frontiere, rapporti con gli stati esteri. Credo che potrei continuare con altri due o tre esempi ma credo anche di essermi spiegato.
In un contesto di informazioni cosi’ complesse e difficili da digerire (per come le percepisco io, ho sempre la netta impressione di *sottovalutarne* la complessita’) i partiti non riescono a mostrare che la loro posizione politica di fondo conduce ad un metodo per trattare con ciascuno dei problemi di cui le informazioni parlano, e i piccoli gruppi cercano di sopravvivere arrangiandosi.
Pingback: Un bilancio onesto cercasi. E partecipato | La casa di Roberto