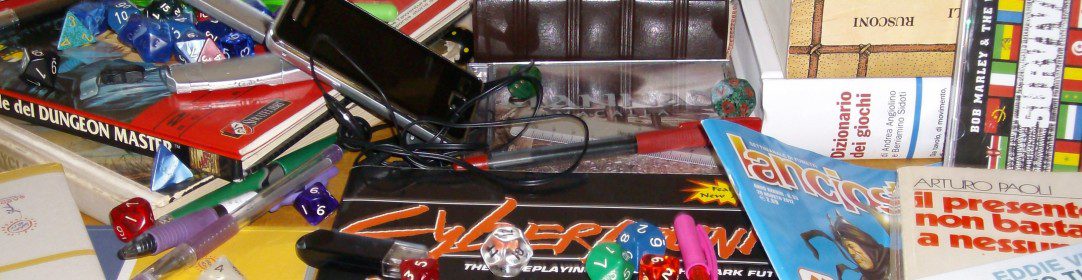Dio dei nostri padri
Quando Blaise Pascal morì gli fu trovato un foglietto all’interno della fodera della giacca, dove l’aveva accuratamente cucito e scucito ogni volta che si faceva un abito nuovo.
Sul foglietto era scritta una confessione di fede che iniziava: «Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe. Non Dio dei dotti e dei filosofi. […] Dio di Gesù Cristo».
Il Memoriale di Pascal è oggetto di molte discussioni relative al rapporto fra fede e scienza, ma non è questo che mi interessa. È che mi sono ricordato l’episodio, che Enzo Bianchi propone all’inizio della sua introduzione a Il cammino dell’uomo di Martin Buber, quando l’altro giorno ho visitato la chiesa di San Benedetto a Mals im Vinschgau (Malles Venosta) e di nuovo ieri al monastero benedettino di San Giovanni Battista a Müstair, nell’Engadina svizzera.
Ero alla caccia di affreschi carolingi, cioè dipinti fra l’VIII e il IX secolo.
San Giovanni era un monastero ricco e potente, fondato nientemeno che da Carlo Magno, e il grandioso ciclo pittorico che ne ornava la chiesa – e l’altrettanto meraviglioso ciclo romanico che l’ha sostituito – in un certo senso non stupisce: si respira, in fondo, un’aria di cristianesimo istituzionale, fra imperatori e luoghi di culto crocevia delle migliori correnti culturali europee di quell’epoca.
Ma San Benedetto, una chiesa piccola di un villaggio di montagna, è un piccolo miracolo.
 Non solo perché in una chiesa così piccola si sono conservate tante cose importanti di cui una, il ritratto praticamente unico al mondo di un ignoto dignitario carolingio fondatore della chiesa, è un capolavoro di introspezione psicologica: accanto a lui l’altro co-fondatore, un religioso, è tutto volto a Cristo cui offre un modello della chiesa; ma lui, uomo di spada, guarda corrucciato e imperioso verso i fedeli, nei confronti dei quali rinnova così la sua autorità.
Non solo perché in una chiesa così piccola si sono conservate tante cose importanti di cui una, il ritratto praticamente unico al mondo di un ignoto dignitario carolingio fondatore della chiesa, è un capolavoro di introspezione psicologica: accanto a lui l’altro co-fondatore, un religioso, è tutto volto a Cristo cui offre un modello della chiesa; ma lui, uomo di spada, guarda corrucciato e imperioso verso i fedeli, nei confronti dei quali rinnova così la sua autorità.
 Non è solo per questo, che pure basterebbe e però sotto questo solo punto di vista Müstair è più importante artisticamente e infatti l’UNESCO l’ha proclamata patrimonio dell’umanità e San Benedetto no. No, la cosa che mi ha colpito è che i due fondatori della chiesa sono persone realmente esistite e viventi al momento nel quale sono state ritratte, persone la cui presenza, su quelle pareti, rimanda a una fede reale e a una comunità reale, non a equilibri geopolitici, a rapporti fra imperatori e re e al cambiare delle mode artistiche o dei rapporti fra ordini religiosi che si sostituiscono gli uni agli altri.
Non è solo per questo, che pure basterebbe e però sotto questo solo punto di vista Müstair è più importante artisticamente e infatti l’UNESCO l’ha proclamata patrimonio dell’umanità e San Benedetto no. No, la cosa che mi ha colpito è che i due fondatori della chiesa sono persone realmente esistite e viventi al momento nel quale sono state ritratte, persone la cui presenza, su quelle pareti, rimanda a una fede reale e a una comunità reale, non a equilibri geopolitici, a rapporti fra imperatori e re e al cambiare delle mode artistiche o dei rapporti fra ordini religiosi che si sostituiscono gli uni agli altri.
Quelle sul muro erano persone concrete, con una fede concreta, ed erano là davanti a me, emblema di quelle schiere innumerevoli di persone che hanno combattuto la buona battaglia e conservato la fede affinché anch’io, migliaia di anni dopo, potessi conoscere il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, Dio del conte Geroldo, della suora Margriata, del monaco Verendario, del contadino Lupicino e di chissà quanti altri.