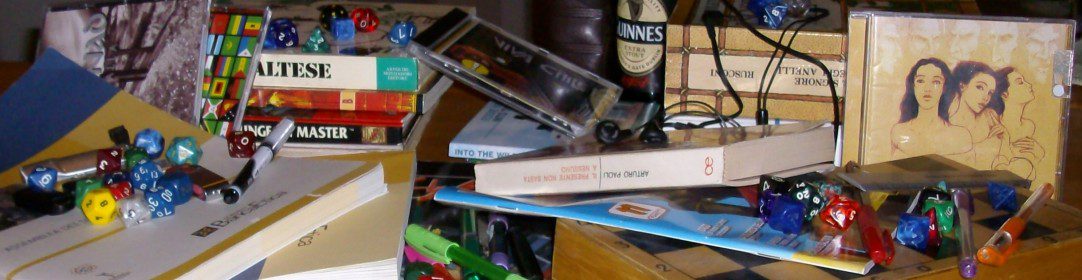Stimarsi a vicenda
Punti di partenza inaspettati
Questo articolo ha a che fare con l’animazione dei gruppi ma, come spesso mi accade, prende spunto da cose magari inaspettate.
Dunque, ieri ero al matrimonio di Grazia e Massimo e la seconda lettura diceva:
La carità non abbia finzioni: fuggite il male con orrore, attaccatevi al bene; amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda. Non siate pigri nello zelo; siate invece ferventi nello spirito, servite il Signore. Siate lieti nella speranza, forti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, solleciti per le necessità dei fratelli, premurosi nell’ospitalità.
Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete con quelli che sono nel pianto. Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri; non aspirate a cose troppo alte, piegatevi invece a quelle umili. Non fatevi un’idea troppo alta di voi stessi.
Non rendete a nessuno male per male. Cercate di compiere il bene davanti a tutti gli uomini. Se possibile, per quanto questo dipende da voi, vivete in pace con tutti (Romani 12,9-18).
È un brano che conosco bene, non solo perché è stato letto anche al nostro matrimonio ma anche perché a suo tempo io e don Ferdinando Caschili ce lo siamo reciprocamente palleggiato come applicabile alle varie situazioni dell’Azione Cattolica diocesana ai tempi nei quali ero responsabile del Settore adulti, e quindi per questi motivi ci sono tornato sopra spesso.
Di solito il brano mi stuzzica per il sano pragmatismo – per niente sentimentale – del versetto finale, con la sua doppia condizione
Se possibile, per quanto questo dipende da voi, vivete in pace con tutti
ma in realtà quello di cui voglio parlare prende le mosse da un altro versetto, il 10b:
gareggiate nello stimarvi a vicenda.
Un consiglio fondamentale per il successo delle organizzazioni, cosa che Paolo, scrivendo, aveva esattamente in testa: il brano si legge ai matrimoni per motivi ovvi, ma è soprattutto una regola di convivenza comunitaria e non, come magari si può pensare, una astratta linea guida morale.
Un esempio narrativo
Per spiegare quel che voglio dire, userò una storiella che ho letto una volta in un libro, chissà quale, del Cardinal Martini e che mi sono andato a ricercare sulla rete:
La storia racconta di un monastero che stava vivendo tempi difficili. In passato aveva ospitato un ordine importante, ma in seguito a un’ondata di persecuzioni antimonastiche verificatesi nel diciassettesimo e diciottesimo secolo e a una crescente tendenza verso il secolarismo nel diciannovesimo secolo, tutti i suoi conventi secondari erano andati distrutti e l’ordine era rappresentato soltanto dall’abate e altri quattro monaci, tutti ultra settantenni, che vivevano nella cadente abbazia. Era chiaramente destinato a scomparire.
Nel fitto bosco che circondava il monastero, si trovava una piccola capanna che un rabbino proveniente da una città vicina usava di tanto in tanto come eremo […] l’abate decise di recarsi all’eremo e di chiedere al rabbino se non avesse alcun consiglio da dargli per salvare il monastero.
Il rabbino accolse l’abate nella capanna, ma quando l’abate gli spiegò lo scopo della sua visita, il rabbino non poté far altro che condividere il suo dolore. […] Così si lamentarono insieme il vecchio abate e il vecchio rabbino. Poi lessero alcuni brani dalla Torah e presero a conversare serenamente di profonde questioni spirituali. Venne per l’abate il momento di andarsene e i due si abbracciarono. «È stato meraviglioso incontrarsi dopo tutti questi anni», disse l’abate, «ma venendo qui non ho raggiunto il mio scopo. Non c’è nulla che puoi dirmi, nessun consiglio che puoi darmi, per aiutarmi a salvare il mio ordine dalla morte?». «No, mi dispiace», rispose il rabbino, «non ho consigli da darti. L’unica cosa che posso dirti è che il Messia è tra voi».
Quando l’abate tornò al monastero i monaci gli si radunarono intorno e gli chiesero: «Ebbene, cosa ti ha detto il rabbino?». «Non è stato in grado di aiutarmi», rispose l’abate. «Abbiamo soltanto pianto insieme e letto la Torah. L’unica cosa che mi ha detto, proprio mentre me ne stavo andando, è stato qualcosa di oscuro. Ha detto che il Messia è tra noi. Ma non so cosa intendesse».
Nei giorni, nelle settimane, nei mesi che seguirono, i vecchi monaci rifletterono su questa frase chiedendosi se le parole del rabbino avessero un qualche particolare significato. Il Messia è tra noi? Voleva forse dire che il Messia è uno di noi? E se è così, chi? Intendeva forse l’abate? Si, se si riferiva a qualcuno, probabilmente si riferiva all’abate. Ci ha guidati per più di una generazione. D’altra parte avrebbe anche potuto riferirsi a fratello Thomas. Sicuramente fratello Thomas è un sant’uomo. Tutti sanno che Thomas è un uomo illuminato. Certamente non poteva rifersi a fratel Elred! A volte Elred è irascibile. È una spina nel fianco per tutti, anche se praticamente ha sempre ragione. Chissà se il rabbino non intendesse proprio fratel Elred. Ma sicuramente non fratel Phillip. Phillip è così passivo, una vera nullità. Eppure ha il dono di essere sempre presente quando c’è bisogno di lui. Forse il Messia è proprio lui. Non è proprio possibile che intendesse me. Io sono una persona qualsiasi. Eppure se fosse proprio così? Se fossi io il Messia? Oh no, non io. Non potrei essere così importante per Te, non è vero?
Immersi in questi pensieri, i vecchi monaci cominciarono a trattarsi fra di loro con straordinario rispetto poiché esisteva la possibilità, per quanto remota, che il Messia fosse tra di loro. E per la possibilità, ancor più remota, che il Messia fosse ciascuno di loro, ognuno cominciò a trattare se stesso con altrettanto rispetto.
Accadeva che di tanto in tanto alcuni visitatori si trovassero da quelle parti, quando senza nemmeno rendersene conto cominciarono ad avvertire l’alone di straordinario rispetto che circondava i cinque vecchi monaci, c’era qualcosa di straordinariamente affascinante, persino irresistibile. I visitatori cominciarono a tornare per fermarsi a pregare, portarono gli amici e gli amici portarono altri amici.
Accadde così che qualcuno di loro iniziò a intrattenersi sempre più frequentemente con i monaci. E dopo qualche tempo uno chiese di potersi unire a loro. Poi un altro e un altro ancora. Così, nel giro di pochi anni, il monastero riprese a ospitare un ordine prosperoso e, grazie al dono del rabbino, tornò a essere un vivo centro di luce e di spiritualità.
Ora, il brano è, con tutta probabilità un falso brano di spiritualità ortodossa; vedo che in ambienti protestanti americani è attribuito indirettamente al dott. Peck. Però qui casca abbastanza a fagiolo.
Una nota personale
Molti anni fa stavo cominciando a impratichirmi delle tecniche di animazione. Non dico che fossi diventato bravo, ma cominciavo a vedere realizzarsi le conseguenze, nel gruppo, di quello che facevo; ad azione cominciava sempre a seguire la reazione: se fossi stato un oratore avrei potuto dire che ero diventato in grado di chiamare l’applauso a comando.
Un giorno stavo raccontando a qualcuno che avevo architettato questo e quello e allora il gruppo aveva reagito esattamente così e cosà proprio come mi aspettavo quando mi venne in mente: «Aspetta un attimo. Esattamente cosa sto facendo?».
Perché parlavo delle persone del mio gruppo con la stessa sensibilità con la quale un chimico descrive le reazioni degli atomi dopo che ha sottoposto un composto a riscaldamento. Solo che non erano atomi, erano persone.
Mi vergognai abbastanza, cosa della quale sono sempre stato grato alla Provvidenza: avrò fatto molti errori, in vita mia, ma mai quello di trattare le persone dei gruppi nei quali lavoravo come oggetti.
E insomma, in quel momento mi coniai una sorta di regola, che mi è capitato poi spesso di citare nei corsi per formatori: per poter animare bisogna voler bene.
Chi di voi ha mai smascherato un formatore – al lavoro, magari, o nello studio – che trattava le persone come oggetti, affidandosi puramente a trucchi comunicativi e manipolazioni, e dopo averlo smascherato ha provato profondo disprezzo per lui, concorderà con me: di un bravo animatore o formatore si vede che è interessato alle persone con cui lavora (quando dico “voler bene” qui intendo proprio “voler bene“, ma non lo dico in senso banalmente sentimentale; intendo voler avere cura).
Naturalmente, e i miei insuccessi lo dimostrano bene, questo voler bene è una condizione necessaria ma non sufficiente: poi ci sono bagagli tecnici, competenze e altre cose, senza le quali non si è bravi formatori. E serve fortuna e collaborazione dei componenti del gruppo: non è che a voler bene ci si assicura automaticamente il successo; casomai ci assicura contro una forma particolare di insuccesso.
Una roba curiosamente assente
Dopo aver scritto questo articolo, mi sono andato a rivedere un po’ di testi sull’animazione e la conduzione dei gruppi. Noto che il tema è, grosso modo, quasi totalmente assente, a favore invece di pagine e pagine sulla differenza di ruolo fra l’animatore o conduttore del gruppo e i partecipanti, i vari stili di leadership eccetera: al massimo quel che si trova sono blande avvertenze a non spingere troppo il pedale sulle dimensioni motivazionali per non rischiare di apparire manipolatori. Ma raccomandare di voler bene è un consiglio positivo (mettere), mentre l’invito a non essere (troppo) manipolatori esprime una dimensione negativa (togliere). E poi naturalmente ci sono gli inviti all’empatia, ma anche qui non si coglie il centro della questione: anche animatori manipolatori possono essere empatici, anzi ogni manipolazione richiede la capacità di mettersi nei panni dell’altro.
Ci sono varie sintesi più o meno ben fatte sulla leadership (esempio): se ci date un’occhiata vedrete che il tema ritorna speso ma non è mai centrato (e tanto meno nei testi base degli autori che vengono poi sintetizzati in queste volgarizzazioni): il problema è che normalmente si ha in mente un paradigma che è sempre orientato alla produzione o comunque al risultato, e quindi si ragiona su quegli stili di leadership che siano più efficaci a seconda delle situazioni. D’altra parte gli studi sul benessere organizzativo tengono in conto un gran numero di variabili in più rispetto a quelle relative alle relazioni interpersonali: per esempio il comfort dell’ambiente di lavoro.
Non ci avevo mai pensato prima, ma a occhio il punto è che Paolo non sta parlando di come condurre una comunità; in termini sociologici piuttosto ha in mente un processo di costruzione di capitale sociale, interno alla comunità ma anche esterno: un approccio piuttosto interessante anche in termini contemporanei. E, seguendo questa linea, mettere insieme gareggiate nello stimarvi a vicenda e per animare bisogna voler bene vuol dire iscrivere la gestione del gruppo nell’area della crescita del suo capitale sociale e non delle sue capacità operative – e tacitamente ipotizzare che un gruppo ben dotato di capitale sociale sarà anche un gruppo che naturalmente evolverà verso una operatività di successo, esattamente come i monaci dell’apologo che vi ho citato; un’ipotesi sulla quale vedo problemi, ma certamente piuttosto provocante.